Anno A/15 Novembre 2020
Pr 31, 10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5, 1-6; Mt 25, 14-30
Prima di entrare nel racconto della Passione, Matteo pone sulle labbra di Gesù un grande discorso, l’ultimo dei cinque con cui articola tutta la struttura del suo evangelo: il discorso escatologico, un discorso in cui Gesù porta i suoi ascoltatori a guardare il fine della storia, la meta della storia; ed in quella meta annunzia l’evento del ritorno del Figlio dell’uomo. Un discorso che presuppone che questo Figlio dell’uomo (modo con cui Gesù stesso si è di continuo designato nell’evangelo) debba andar via per poi tornare; presuppone dunque, ed il lettore dell’evangelo lo capisce bene, la Pasqua di Gesù. Egli sarà sottratto alla storia ma poi tornerà, e questo ritorno richiede un atteggiamento essenziale: la vigilanza.
A conclusione del discorso escatologico, proprio per inculcare la necessità di questo atteggiamento di vigilanza, Matteo pone tre parabole: la parabola delle dieci vergini, questa di oggi dei talenti, e la parabola che ascolteremo domenica prossima del giudizio finale.
L’accento che si pone nelle
prime due parabole è sulla vigilanza; e se per la parabola delle dieci
vergini risulta chiarissimo, lo è forse un po’ meno per la
parabola dei talenti, o almeno non è così evidente. Basta
tuttavia leggere la conclusione della precedente parabola, per coglierne
il tema della vigilanza. Vegliate,
dunque, perché non sapete né il giorno, né l’ora. Avverrà
infatti come di un uomo che, dovendo partire per un viaggio.
Quell’“infatti” (in greco gàr” è allora
importantissimo, proprio perché collega la parabola dei talenti al tema della
vigilanza.
Matteo racconta una parabola (anche questa spesso letta in modo
moralistico e volontaristico!) con cui – partendo da un’implicita domanda sul
tipo di rapporto che instauriamo con Dio – giunge a declinare la vigilanza come
capacità di rischiare per mettere in moto i doni ricevuti dal
Signore, che è partito nel suo Esodo, ma che poi tornerà.
Il primo problema che il racconto di Matteo pone è quello della relazione che
c’è tra il terzo servo, il vero protagonista della parabola (quello
cioè su cui puntare tutta l’attenzione per comprendere il messaggio), ed il
Padrone.
La parabola è un racconto “a sorpresa”, un racconto in cui il lettore è portato
a schierarsi dalla parte sbagliata. Un po’ come avveniva con la parabola
degli operai dell’ultim’ora (cfr Mt 20, 1-16), dove
il lettore, di istinto, era spinto a sottolineare l’“ingiustizia” del
comportamento del padrone della vigna, che paga in modo indistinto
gli operai a prescindere dalle ore di lavoro e di calura.
Qui, nella parabola dei talenti, si è portati a pensare che
l’atteggiamento “prudente” del terzo servo non sia poi così sbagliato:
anche noi ragioniamo come lui, e ci convinciamo che tutto è giunto a
buon fine, perché il talento è tornato intatto al Padrone! Il
servo, in fin dei conti, non ne ha approfittato; non ha rubato nulla,
né ha usato quel ben di Dio (circa 32 chili di oro!) per suoi scopi
personali! Ha conservato il talento con diligenza, e ha fatto anche
attenzione a che nessuno toccasse quel patrimonio!
Il lettore ragiona così, come il terzo servo, e si trova tuttavia dalla parte
del torto!
La narrazione di Matteo ci conduce a comprendere che questo avviene perché non
si sa bene chi sia il Padrone, ed è chiaro che questi nella parabola adombri
Dio! Il terzo servo lo definisce come un uomo duro, un
uomo che miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso!
Ecco il tranello!
Dinanzi ad una simile concezione di Dio non c’è spazio se non per due
atteggiamenti: la paura ed il legalismo. Sono i due
sentimenti che hanno guidato il servo a sotterrare il talento: ha avuto un
talento ed un solo talento ha restituito, osservando una banale legge di onestà
e di prudenza. Ha avuto paura di trattare con quel padrone “duro”, non ha
voluto discussioni con Lui sul suo comportamento circa il traffico di quel
talento; e per paura, ha creduto di
risolvere il tutto in modo legalistico!
Si deve perciò tornare alla domanda iniziale della
parabola: che significa vigilare (in
greco gregoréo)? Nella parabola delle dieci vergini, vigilare
significa essere equipaggiati per un tempo lungo. Qui, invece,
c’è una risposta ulteriore: vigilare significa assumersi responsabilmente il
quotidiano; e “responsabilmente” vuol dire “rischiando”!
La parabola, allora, ci dice che il problema risiede tutto nel
nostro rapporto con il Signore. Il rapporto del terzo servo
con il Signore è di paura: è un servo molto diverso da quello delineato nella
parabola del servo spietato (cfr Mt 24, 42-51),
il quale in fondo non prende sul serio la possibilità di un ritorno del
padrone…
Nella parabola dei talenti, invece, è proprio l’incombere del
ritorno che paralizza il terzo servo, rendendolo infecondo e privo di ogni
iniziativa affinché il dono immenso del Padrone potesse far frutto. Quello
era un dono, e un dono da far fruttare; ma il terzo
servo, non avendo compreso che era un dono (Ecco il tuo!), non l’ha fatto fruttare; ha creduto
perciò di doverlo nascondere, mostrandosi pertanto nella sua verità: un
servo achreîros, un servo “inutile”, e certamente
non nell’accezione positiva, che gli dà l’evangelista Luca, di servo che “non pretende un utile”, di servo cioè che agisce con
gratuità (cfr Lc 17, 10), ma nel senso più brutto del termine: un servo che non
produce nulla, che non genera vita. Un servo che non è fecondo.
La fecondità di cui si sta parlando è una fecondità
che parte dal talento (o dai talenti) che il Signore ha lasciato. La domanda
importante allora è questa: cosa sono questi talenti?
E’ facile cadere qui nei soliti discorsi sulle doti personali,
sulle capacità e le abilità di ciascuno, sui doni che ciascuno ha ricevuto e
così via…nulla di così sviante! Nulla di così sbagliato!
Se andiamo alla struttura della narrazione, ci rendiamo conto che il Signore,
che parte e poi ritorna, è Gesù stesso, e ciò che lascia è la sua esistenza. Infatti, il sostantivo che Matteo qui usa
per definire ciò che sono i talenti è iuparxis (che
abbiamo tradotto con “beni”), termine che certo indica anche la “ricchezza” ed i “mezzi di sussistenza”, ma
questo secondo significato – direi – deriva dal primo: “esistenza”, “esserci in realtà”.
Allora pare lampante: i beni che Gesù lascia alla sua partenza (con la sua
Pasqua) sono quelli dell’Evangelo: è la sua esistenza consegnata agli uomini, è
la sua vita che racconta Dio, con l’amore fino all’estremo (cfr
Gv 1, 18; Gv 13, 1). Ciò che si doveva “trafficare” era l’Evangelo, era l’amore
che può cambiare la faccia della terra. E questo non si può sotterrare,
non si può nascondere (cfr Mt 5, 15). Questo era richiesto al servo “inutile”,
al servo “infecondo”.
Si vigila, allora, solo se si è operosi; e non operosi nell’usare i “propri talenti”, le proprie bravure ed attitudini, ma operosi nel “trafficare” l’Evangelo, prendendolo concretamente sul serio, senza fughe né paure, ma rischiando e pagando di persona.
P. Fabrizio Cristarella Orestano
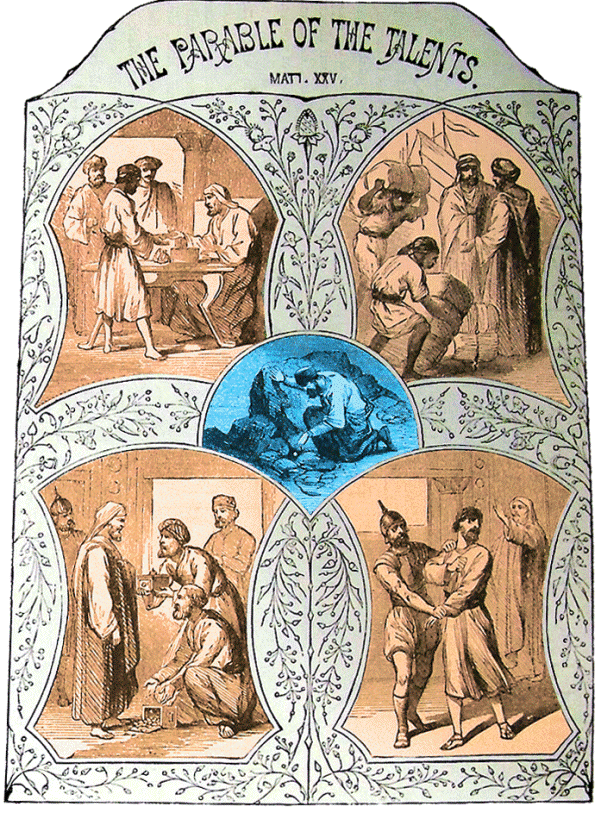
Illustrazione della parabola dei talenti in una Bibbia inglese dei primi del ‘900
